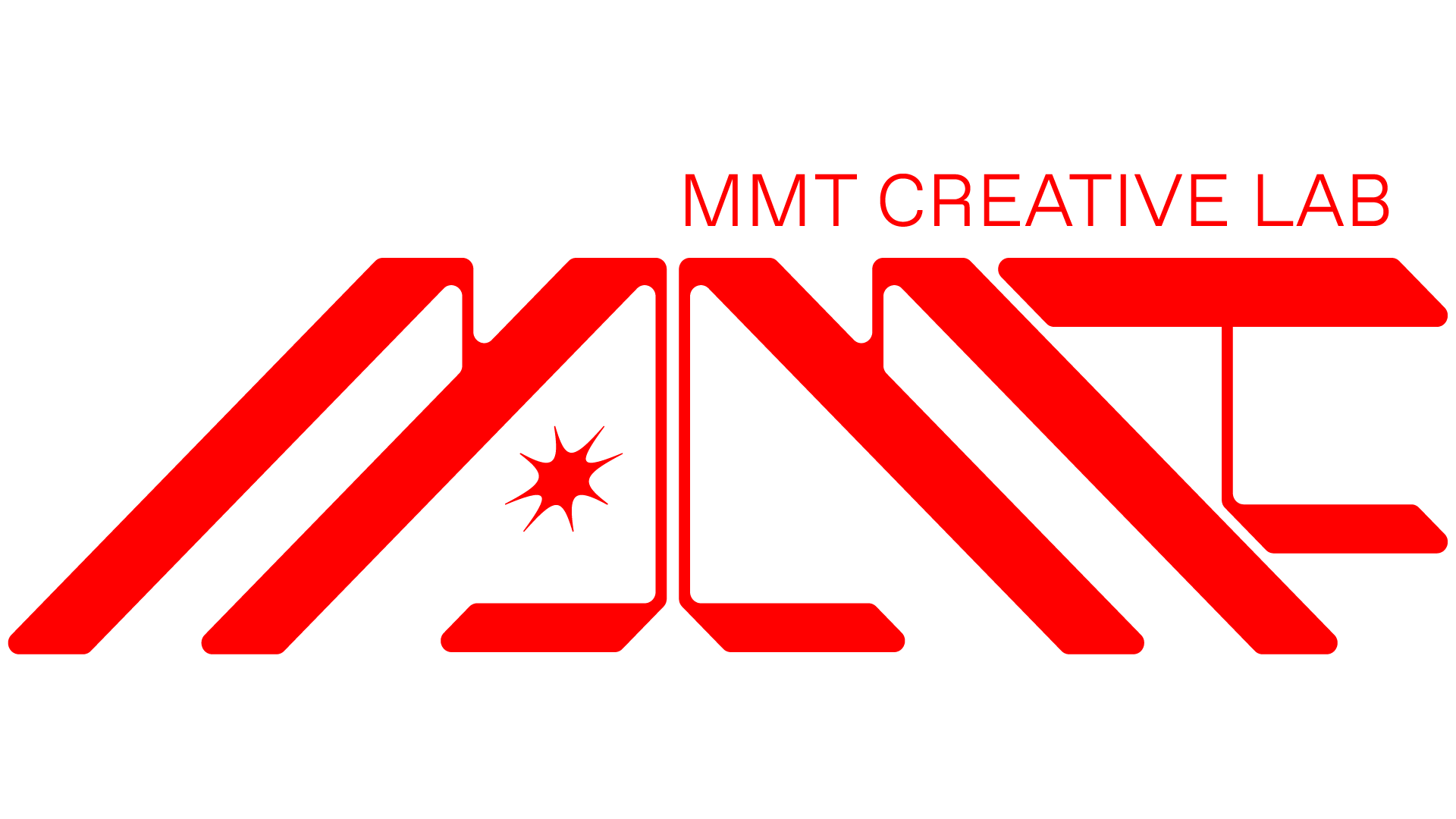19 Jun “Come un cervo che cade dall’alto”.
“Come un cervo che cade dall’alto”
Alcune considerazioni sull’improvvisazione radicale.
di Simone Broglia

Intorno alla metà degli anni sessanta, mentre il boom economico attraversava l’Italia, i miei nonni materni decidono di acquistare una casa di villeggiatura nel varesotto, una delle mete più in voga tra i milanesi in quel periodo.
Più precisamente presero casa a Cittiglio. Cittiglio non è un paese famoso, non lo è ora e non lo era allora per la stragrande maggioranza delle persone. Per alcuni però il nome di quella piccola cittadina è scritto a chiare lettere nella storia: Cittiglio è il paese natale di Alfredo Binda.
Binda il grande ciclista, campione del mondo, maglia iridata, scopritore dei grandi campioni degli anni cinquanta e sessanta, colui il quale più di ogni altro ha traghettato il ciclismo dall’epoca eroica, fatta di strade sterrate, bici di ferro, cerchioni di legno e gladiatori su due ruote con i baffoni ottocenteschi a manubrio, verso un ciclismo sportivo, atletico e tecnico, glorioso e glorificato.
Quando i miei nonni comprarono casa a Cittiglio era il 1961. Binda era ancora vivo, sposato con una donna molto più giovane di lui, così tanto più giovane che alcuni parenti del campione si rifiutarono di presenziare alla cerimonia il giorno del loro matrimonio.
La famiglia Binda abitava nella vecchia casa padronale, appena fuori dal paese, sulla strada che porta da Cittiglio al passo Cuvignone, 1000 metri circa sul livello del mare. Proprio questa strada, fatta di tornanti che tagliano un bosco prealpino di querce e castagni e che salgono con una pendenza media del 10% divorando un dislivello di 800 metri circa, è la strada che ha forgiato le gambe di Alfredo Binda durante migliaia di allenamenti in sella. Una strada così tanto indelebilmente legata alla memoria del campione che oggi è stata a lui intitolata, così come la rotonda all’ingresso del paese e il piccolo museo, e chiamata “Cronoscalata Alfredo Binda”. Sull’altro versante dello stesso monte, per salire al Cuvignone corre la “Cronoscalata Ivan Basso”. Ogni ciclista sceglie da che parte salire e da che parte scendere, a seconda dell’umore e dello spirito più o meno modernista o nostalgico. Io scelgo sempre di salire dalla Binda e spesso di ridiscendere dalla stessa. Sia per me sia per mio padre, appassionati ciclisti della domenica, la Cronoscalata Binda è una tappa annuale obbligatoria, quella che scalda le gambe prima di provare salite più impegnative o più in quota, prima di spostarsi sui passi duri delle Alpi. Non è solo questione di allenamento, ma anche di comodità, visto che l’attacco della “Binda” si trova relativamente vicino alla casa dei miei nonni.
Insomma, è stato così che nel giro di un paio anni la bellezza della salita, unita alla comodità dell’avvicinamento e al revival del ciclismo epico (e anche etico) d’antan, ha fatto si che in famiglia si ritualizzasse la Cronoscalata Binda come una tappa fondamentale per i muscoli e per lo spirito. Un sabato mattina di fine primavera di qualche anno fa, pur trovandomi in una Milano dal tempo pessimo, sento una gran voglia di prendere la bicicletta da corsa, macinare un po’ di tornati e godermi una bella discesa. Metto la bici in macchina e al volo parto per Cittiglio e la Cronoscalata Binda.
9.30 inizio la salita. 9.40, passo davanti alla casa del celebre corridore. 9.50, m’infilo nel bosco e il cellulare non prende più. La salita è ripida, soprattutto all’inizio. Nel bosco vengo avvolto dalla nebbia, nebbia umida, di quelle che salgono con i primi raggi di sole dopo una notte piovosa.
Una nebbia di cui comunque non avrò da preoccuparmi fino al momento della discesa, visto che, durante tutta la salita, la fatica dei tornanti mi farà tenere lo sguardo fisso sull’asfalto per non perdere il fiato. Dopo essermi lasciato alle spalle la metà del dislivello, mentre penso a quando Binda percorreva questi tornanti senza i miei rapporti, con una bici molto più pesante e dei mattoni legati alle spalle (almeno così vuole la leggenda), inizio a sentire dei rumori provenire dal bosco. Butto uno sguardo rapido a monte. Non vedo nulla.
Continuo a pedalare, i rumori si fanno ravvicinati. Mi guardo attorno, ma i fitti cespugli di rovi, che riempiono il sottobosco prealpino e coprono la base degli alberi a foglia larga, non mi permettono di vedere più in là di un metro un metro e mezzo. Così, giusto precauzionalmente, mi sposto un po’ dal pendio a monte e pedalo nel mezzo strada. A un certo punto una serie di rumori consecutivi mi distoglie con prepotenza dalla pedalata e sbum, sfrr, stum, crak, tac e alla fine voillà: un cervo in carne e ossa mi vola accanto. Piombato giù dal cielo, scivolato e carambolato giù per il pendio che si trova alla mia destra. Me lo trovo vicino, dritto in piedi dopo l’ultima giravolta e gli inutili tentativi di fare presa con gli zoccoli. Nel senso di straniamento generale, mio e suo, nessuno dei due mette in mostra la propria paura. Per un breve tratto viaggiamo affiancati, spaventati e incuriositi entrambi. Proseguiamo dritti lungo la strada su traiettorie parallele che orientano a vicenda i propri spostamenti senza mai collidere, fortunatamente.
Il cervo salterella e io pedalo stanco, ci teniamo d’occhio, ma nessuno dei due si ferma, fino a quando lui, o lei, sfoga la sua adrenalina e trova un varco per intrufolarsi nuovamente nel bosco a valle della strada.
Io continuo la salita fino al passo Cuvignone e poi mi godo la discesa.
Perché ho deciso di cominciare da qui? Perché più volte mi sono trovato a prendere parte a serate e concerti d’improvvisazione radicale e a pormi delle questioni. Questioni banali di un “non musicista”, di uno che non può partecipare attivamente alla performance, ma che allo stesso tempo ama prenderne parte e mi sono trovato in difficoltà nel razionalizzarle, nel presentarle in modo che fossero condivise, che se ne potesse parlare. Ho cominciato da questo racconto fondamentalmente per due ragioni, la prima è che trattandosi di considerazioni ancora del tutto personali, non ancora condivise con alcuno, mi sembra opportuno partire da un’esperienza personale. E la seconda è che in fondo, per un ascoltatore, assistere a una performance d’improvvisazione radicale è paragonabile a un cervo che cade dall’alto: un evento anomalo, strano, inclassificabile. Un evento, o una serie di eventi, che non danno lo spazio di parola o pensiero, che cadono addosso senza preavviso e senza la possibilità di essere previsti. Detto questo cerchiamo ora di fare un po’ di luce sulla tematica dell’improvvisazione radicale e della performance, vista dalla parte dell’ascoltatore, sfruttando un po’ il racconto.
Ci sono tre elementi focali per inquadrare il momento di un’improvvisazione: il contesto, i gesti e i soggetti. Andiamo con ordine: un cervo che cade dall’alto, in sé e per sé, è un evento assolutamente inclassificabile, che diventa però molto più normale nel momento in cui assumiamo coscienza del contesto in cui si svolgono i fatti: all’interno di un bosco, dove la presenza umana tace, un cervo che saltellando perde l’appiglio e rotola a valle non è nulla di strano. Allo stesso modo allora trovo efficace inquadrare l’ascolto di una performance in questa tipologia di relazionalità con il contesto, la situazione. Semplifichiamo così, solo al fine di approfondire in seguito, dicendo che, ad esempio, un trombettista che parla nella tromba sarebbe un evento molto strano se stessimo assistendo al Concerto per tromba e orchestra di Haydn, lo sarebbe un po’ meno durante un’ipotetica performance per tromba, voce ed elettronica. Non è solo questo però il contesto.
La relazione dell’ascoltatore con l’evento vive e si nutre della contestualità. Proprio a proposito di questo vorrei fare una precisazione sulla scelta del racconto. La mia scelta di partire da un contesto così poco culturale per parlare di un fenomeno che solitamente viene letto a partire da strutture culturali e concettuali, vuole essere un punto importante per cercare di aprire una luce diversa sull’improvvisazione e sull’ascolto, togliendoli da una lettura culturalistica e affidandoli a una lettura più “naturalistica”, estetica e precettiva. Alla luce di questa prima considerazione allora il termine contestuale assume un significato molto diverso da quello che solitamente gli si attribuisce negli eventi culturali (cioè un modo consolidato e dominante di pensare e percepire) filtrato necessariamente da una griglia culturale, ma diventa l’insieme di tutti gli agenti, i percipienti, delle loro traiettorie decisionali, delle premesse e delle conseguenze esterne che intrecciandosi danno vita a infinite micro-azioni di cui scegliamo di esaminare un’azione specifica. In sostanza è un’estensione della nozione di ambiente, un “ambiente vissuto”, potremmo dire, semplificando un po’ anche qui. All’interno di un contesto, sia esso un bosco nebbioso e silenzioso in cui un ciclista si muove senza disturbare la quiete di un cervo che protetto dalla nebbia e rassicurato dal silenzio si avvicina con poca prudenza ad una strada, oppure una sala dove si prepara una performance, molte azioni si compiono e si subiscono, si attivano emozioni e stati d’animo, si mescolano con casualità scelte più o meno consapevoli a reazioni emozionali. È un contesto agito dove si muovono cervo e ciclista, così come ascoltatore e performer, è una situazione che si rigenera in continuazione, vissuta attivamente dai due soggetti in gioco, fatta di gesti e azioni che causano reazioni.
Ecco dunque emergere in questo contesto vissuto come un campo di azione, il secondo elemento: i gesti. All’interno di un contesto vivo, attivo, dove l’interazione tra più elementi è il presupposto, ogni gesto, ogni singolo movimento assume una densità di significato che lo rende protagonista. Ogni gesto diventa un nodo, un punto essenziale di quel campo. Pensiamo all’evoluzione di un’improvvisazione in cui ogni scelta orienta e disorienta allo stesso tempo l’ascoltatore, ogni gesto porta l’ascoltatore verso una trama di rimandi e riferimenti che non trovano un porto su cui attraccare, ma che vivono nello scambio e nella relazione tra attore e recettore. Il gesto qui non è mai neutro, non è mai scontato, non si limita mai all’esecuzione della nota, perché ogni suono porta con sé la fisicità di un rapporto con lo strumento suonato. Ogni suono diventa così un gesto sonoro generato da una relazione istintuale; i gesti misurati, calibrati e finalizzati all’emissione della giusta vibrazione, all’interno dell’improvvisazione radicale devono cedere spazio alle decisioni del momento, alla possibilità di sentire e non solo di eseguire. La scelta di una successione di gesti sonori diventa uno dei modi possibili per i soggetti in gioco di relazionarsi, di entrare a far parte di quel contesto. Infatti è dalla loro evoluzione che dipendono le sorti della relazione in corso, quella tra chi suona e chi ascolta, oppure tra chi bruca e chi pedala per tornare un po’ al racconto.
Arriviamo così al terzo e ultimo elemento dell’analisi: i soggetti. Dunque, ricapitoliamo. Abbiamo voluto parlare dell’improvvisazione radicale, e in modo più ampio della performance, partendo da un racconto e sostenendo la necessità di fare luce su tre elementi: il contesto, letto come ambiente vivo e animato; i gesti, che riempiono e danno senso allo sviluppo delle azioni nel contesto; i soggetti, che si muovono e diventano protagonisti delle azioni nel contesto stesso. Infatti, attraverso i gesti, i soggetti in gioco orientano vicendevolmente il proprio stare in quel contesto, in quell’ambiente. Intendiamo, non stiamo parlando di un’interazione diretta nello sviluppo sonoro dell’improvvisazione, ma piuttosto un affiancamento, una compartecipazione all’ambiente che essendo in continua evoluzione può essere sfumato, virato, orientato diversamente a seconda dell’incontro. In questo senso allora i soggetti che partecipano dell’ambiente e del suo essere vivo orientano immancabilmente gli accadimenti. Nel gioco istintuale, percettivo ed emotivo, musicista e ascoltatore, durante l’improvvisazione, si trovano a condividere un tratto di strada, come cervo e ciclista, un momento di affiancamento, di curiosità e circospezione, in cui presentare i propri gesti e le proprie reazioni emotive. Il performer propone, si espone alla luce di un mood di un contesto, mentre l’ascoltatore aspetta condividendo la situazione, l’atmosfera, fino al momento dell’incrocio, della rottura dell’omeostasi, del rumore, del silenzio o del gesto sonoro radicale. Alla luce di tutto questo torniamo allora a domandarci cosa è assistere a una performance, a un’improvvisazione per un ascoltatore. Bene, potremmo dire che l’ascoltatore curioso che partecipa a una performance d’improvvisazione, a differenza di altri contesti musicali, si trova a compiere un’esperienza. Vive un’esperienza perché è coinvolto in un processo in divenire di cui è, volente o nolente, parte attiva ed elemento contestuale. Non è solo spettatore di fronte ad uno spettacolo, non è solo uditore davanti all’orchestra, è parte di un organismo vivo che può determinarsi anche sulla base dei suoi gesti. È un’esperienza perché è uno scambio di gesti, gesti di adattamento al contesto di volta in volta nuovo che ci si trova di fronte. Infine è un’esperienza perché l’ascoltatore si trova in gioco come soggetto coinvolto in un contesto e in uno scambio che richiedono la sua partecipazione o il suo rifiuto.
Un’esperienza estetica, che lo mette in contatto con il suono, con la voglia di giocare e manipolare un materiale da parte del performer. Un’esperienza perché si costituisce di uno scambio, di un relazionarsi e integrarsi attivamente. È un’esperienza perché permette all’ascoltatore curioso di scoprire qualcosa di più sulla musica e qualcosa di più su di sé.